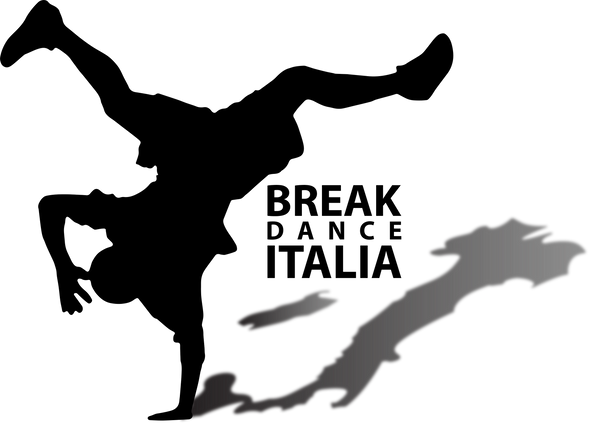Molti ragazzi che vogliono praticare breaking si trovano spesso a dover iniziare il loro percorso all’interno di una scuola di danza.
Soprattutto nelle realtà più piccole o nelle zone di provincia, queste scuole rappresentano l’unico punto di accesso alla disciplina, grazie a corsi tenuti da insegnanti locali che hanno conoscenze di cultura hip hop o esperienze dirette nel breaking.
Fino ai 13 anni circa, il saggio di fine anno può anche offrire un valore positivo per i giovani breaker. In questa fase, partecipare a una coreografia può aiutare a sviluppare competenze trasversali: il lavoro di gruppo, la disciplina, la gestione dell’emozione scenica e la coordinazione.
Tuttavia, con l’ingresso nell’adolescenza, la situazione cambia.
Il breaking, per i ragazzi dai 13 anni in su, inizia a diventare qualcosa di più profondo: un linguaggio artistico personale, un mezzo di espressione libera e spontanea, che si fonda sull’improvvisazione, sull’identità individuale e sull’interazione con gli altri.
In questo contesto, la logica del saggio – basata sulla preparazione di una coreografia collettiva, spesso rigida e teatrale – può entrare in contrasto con i bisogni evolutivi del giovane breaker.
Molti adolescenti, infatti, iniziano a percepire il tempo dedicato alla preparazione del saggio come tempo sottratto alla propria crescita artistica.
Non si tratta di semplice insofferenza: si genera una frustrazione reale, che può portare a risentimento verso la scuola e, in alcuni casi, anche ad abbandonare la scuola col rischio che si estenda alla disciplina stessa mancando la pratica e continuità.
Il breaking non è una danza da eseguire tutti uguali sotto i riflettori, ma un percorso fatto di ricerca personale, errori, confronti, sfide e libertà.
Questo articolo si propone di analizzare, da una prospettiva pedagogica, culturale e psicologica, perché non è opportuno imporre la partecipazione al saggio ai breaker adolescenti senza il loro consenso.
Vogliamo offrire spunti concreti per le scuole, affinché possano valorizzare il percorso dei giovani breaker senza tradirne l’identità e senza rinunciare alla funzione educativa e comunicativa del saggio stesso.
1. Il breaking come linguaggio autonomo: differenze con l'hip hop coreografato
Una delle prime distinzioni necessarie riguarda la confusione tra breaking e "hip hop" coreografico da palco. Spesso, nelle scuole di danza, queste due espressioni vengono trattate come intercambiabili. In realtà, il breaking è una disciplina autonoma, con una sua storia, un suo linguaggio tecnico e una sua funzione socio-culturale specifica.
Come scrive Joseph Schloss in Foundation: B-Boys, B-Girls and Hip-Hop Culture in New York (Oxford University Press, 2009), il breaking è un'arte fondamentalmente improvvisativa, in cui l'individualità, la capacità di rispondere alla musica in tempo reale, e l'originalità del movimento sono centrali. A differenza delle coreografie teatrali, il breaker non riproduce un'idea altrui, ma manifesta il proprio stile.
Il palco del teatro, con la sua frontalità e rigidità, si contrappone alla circolarità dei cypher e alla logica del confronto orizzontale tipica delle battle. Imporre a un adolescente breaker la partecipazione a una performance coreografata, spesso su musica e struttura non scelta, equivale a neutralizzare la sua agency, cioè la sua capacità di autodeterminarsi artisticamente.
2. L'adolescenza e il bisogno di identità artistica: un quadro psicologico
Secondo la teoria dello sviluppo psicosociale di Erik Erikson (Identity: Youth and Crisis, Norton, 1968), l'adolescenza è la fase in cui l'individuo cerca di costruire un'identità coerente. Questo processo include la differenziazione dai modelli imposti e la scoperta della propria voce. In ambito artistico, ciò si traduce nella volontà di scegliere cosa esprimere, come e dove.
La teoria dell'autodeterminazione di Edward Deci e Richard Ryan (2000) offre una chiave ulteriore: la motivazione intrinseca, cioè quella più profonda e duratura, nasce quando l'individuo si sente autonomo, competente e relazionato con l'ambiente. Forzare la partecipazione a un saggio che non si sente proprio mina queste tre dimensioni.
Numerose ricerche in ambito educativo e sportivo mostrano che la motivazione autonoma è correlata con la persistenza nella pratica. Al contrario, la motivazione controllata o estrinseca è associata a drop-out, frustrazione e abbandono precoce. E questo è esattamente ciò che accade in molte scuole: l'allievo adolescente, costretto a un format che percepisce come estraneo, lascia il corso di breaking proprio quando dovrebbe consolidare la sua crescita.
3. Coerenza culturale e rispetto per la disciplina
Il breaking non è solo uno stile di danza, ma è parte di una cultura più ampia, quella hip hop, che affonda le sue radici nelle comunità afroamericane e latinoamericane del Bronx degli anni Settanta.
Come sottolinea Christina Zanfagna in Holy Hip Hop in the City of Angels (University of California Press, 2017), l'hip hop è prima di tutto una risposta politica e creativa a condizioni di marginalità sociale. Il breaking è nato nei cypher e nei block party, non nei teatri. La sua forza risiede nella libertà espressiva, nella competizione costruttiva, nella ricerca del flow personale.
Quando una scuola impone il saggio senza dialogo, non solo non rispetta l'identità dell'allievo, ma snatura la disciplina stessa, svuotandola della sua potenza culturale. Questo alimenta un modello in cui il breaking viene assimilato a una danza scenica qualsiasi, perdendo la sua specificità.
4. Gli effetti sulla relazione pedagogica: dalla guida all'imposizione
Ogni buon educatore sa che l'efficacia di un percorso dipende dalla qualità della relazione con l'allievo. Quando si passa dalla proposta al comando, dalla mediazione al diktat, la relazione si deteriora. E l'adolescente, in particolare, ha un radar finissimo per riconoscere chi lo ascolta e chi lo ignora.
Molti insegnanti di breaking raccontano che i momenti di maggiore crescita nei propri allievi si verificano quando viene data fiducia, quando si favorisce la responsabilizzazione, non quando si impone una scelta che non tiene conto del loro vissuto. L'obiettivo non dovrebbe essere quello di "farli esibire", ma di farli crescere attraverso l'espressione autentica.
In quest'ottica, il saggio può esistere, ma come opportunità scelta, non come obbligo. E laddove non è coerente con il percorso individuale, è compito dell'insegnante e della scuola trovare alternative.
5. Alternative praticabili: jam, battle, cypher e formati ibridi
Se il fine dichiarato del saggio è davvero quello di mostrare i progressi e i risultati raggiunti, e non semplicemente monetizzare sugli ingressi, allora la scuola ha numerose possibilità per farlo in modo coerente con il linguaggio e l'identità del breaking. Tra queste:
- Freestyle, in cui i breaker improvvisano liberamente di fronte al pubblico;
- Battle dimostrative, in cui gli allievi si confrontano amichevolmente, mostrando tecnica e personalità;
- Jam scolastiche organizzate internamente, con la partecipazione di genitori e amici;
- Video recap dei progressi, con documentazione filmata del percorso dell'anno montata in modo professionale e presentata durante l'evento;
- Progetti coreografici autogestiti, in cui i ragazzi propongono pezzi propri, lavorando in gruppo e presentandoli se lo desiderano.
Tutto questo permette di salvare il valore simbolico del saggio senza tradire la coerenza culturale del breaking. E, soprattutto, evita l'effetto collaterale più grave: la perdita dell'allievo più appassionato.
SCEGLIERE è parte del diventare breaker
A 14 anni, un breaker non è più un bambino. Sta cercando la sua voce, il suo stile, il suo posto nel mondo. Se viene ascoltato, accompagnato e rispettato, quel ragazzo o quella ragazza può diventare un punto di riferimento per altri, un promotore di cultura, un artista. Se viene forzato, probabilmente si allontanerà. E non tornerà.
Non è solo una questione di libertà individuale. È una questione di visione educativa. Le scuole che avranno il coraggio di ascoltare, differenziare, evolvere, saranno quelle che costruiranno il futuro della cultura hip hop in Italia.
Articolo redatto da Breakdance Italia con l'obiettivo di stimolare un confronto costruttivo sul futuro educativo della cultura hip hop.
Fonti principali
-
Schloss, J. (2009). Foundation: B-Boys, B-Girls and Hip-Hop Culture in New York. Oxford University Press.
-
Deci, E. & Ryan, R. (2000). "The 'What' and 'Why' of Goal Pursuits", Psychological Inquiry.
-
Erikson, E. (1968). Identity: Youth and Crisis. Norton.
-
Zanfagna, C. (2017). Holy Hip Hop in the City of Angels. University of California Press.
-
Nicholls, J. (1989). The Competitive Ethos and Democratic Education. Harvard University Press.